![anne sexton anne sexton]() Annoverata tra quei confessional poets che negli anni Cinquanta e
Sessanta rivoluzionarono la scrittura poetica coeva con la messa in scena
di drammi personali ed esplorazioni sfrontate di interiorità ora realmente
patologiche, ora performativamente isteriche, Anne Sexton è stata di certo
una poetessa originale e innovativa. In parte, anche più di Sylvia Plath,
di cui fu amica e alla quale viene sempre accostata (anche qui, invero) in
un confronto che in genere la vede perdente. In realtà, la Sexton fu sì
meno colta e meno raffinata dellaltra ma, a rileggerla oggi, ben più
modernamente ambigua, soprattutto nei confronti della cruciale
rappresentazione, per entrambe, del rapporto uomo-donna. Se infatti la
Plath declina il suo immaginario di ribellione al maschile soprattutto
nella diade padre-marito, la Sexton si confronta con una quaterna
composta da padre, marito, amante e Dio e la investe di
unambivalenza in cui, per esempio, le figure dellamante e del divino si
sdoppiano e si moltiplicano di ruolo. Se lamante può, semplicemente,
essere donna (come fu anche, talora, nella vita della Sexton) o farsi, da
un punto di vista simbolico, figura edipico-paterna, Dio rappresenta sia
lipostasi suprema di un patriarcato puritano e repressivo sia un
accogliente rifugio materno verso cui anelare (e del resto la Sexton dirà
che Dio è donna). Al di là di questo precoce e antesignano tentativo di
andare oltre il genere, la Sexton scompagina le carte dellimperante
femminismo ideologico dellepoca (che invece della Plath fece,
notoriamente, il santino) proprio per la sua feconda irresolutezza nei
confronti del desiderio per luomo-amante. La relazione adulterina e i suoi
oggetti libidici rimangono difatti sempre in bilico tra volontà di fusione
e rifiuto doloroso, erotismo estatico e rabbia rivendicativa, liberazione
fisica e intimo senso di colpa, gioia e angoscia.
Annoverata tra quei confessional poets che negli anni Cinquanta e
Sessanta rivoluzionarono la scrittura poetica coeva con la messa in scena
di drammi personali ed esplorazioni sfrontate di interiorità ora realmente
patologiche, ora performativamente isteriche, Anne Sexton è stata di certo
una poetessa originale e innovativa. In parte, anche più di Sylvia Plath,
di cui fu amica e alla quale viene sempre accostata (anche qui, invero) in
un confronto che in genere la vede perdente. In realtà, la Sexton fu sì
meno colta e meno raffinata dellaltra ma, a rileggerla oggi, ben più
modernamente ambigua, soprattutto nei confronti della cruciale
rappresentazione, per entrambe, del rapporto uomo-donna. Se infatti la
Plath declina il suo immaginario di ribellione al maschile soprattutto
nella diade padre-marito, la Sexton si confronta con una quaterna
composta da padre, marito, amante e Dio e la investe di
unambivalenza in cui, per esempio, le figure dellamante e del divino si
sdoppiano e si moltiplicano di ruolo. Se lamante può, semplicemente,
essere donna (come fu anche, talora, nella vita della Sexton) o farsi, da
un punto di vista simbolico, figura edipico-paterna, Dio rappresenta sia
lipostasi suprema di un patriarcato puritano e repressivo sia un
accogliente rifugio materno verso cui anelare (e del resto la Sexton dirà
che Dio è donna). Al di là di questo precoce e antesignano tentativo di
andare oltre il genere, la Sexton scompagina le carte dellimperante
femminismo ideologico dellepoca (che invece della Plath fece,
notoriamente, il santino) proprio per la sua feconda irresolutezza nei
confronti del desiderio per luomo-amante. La relazione adulterina e i suoi
oggetti libidici rimangono difatti sempre in bilico tra volontà di fusione
e rifiuto doloroso, erotismo estatico e rabbia rivendicativa, liberazione
fisica e intimo senso di colpa, gioia e angoscia.
Propongo dunque qui alcune nuove traduzioni di testi della poetessa
incentrati proprio sul ruolo dellamato-amante. I primi tre provengono da
una delle raccolte più note e fortunate della Sexton, Love Poems
(1969), dedicata al rapporto extraconiugale da lei intrattenuto con il suo
psicoanalista dellepoca, Ollie Zweizung, mentre il quarto proviene
dallopera postuma 45 Mercy Street (1976). Si legge, in queste
poesie della sua maturità, tutta la capacità dellautrice di trasfigurare
il confessionalismo autobiografico in scenari filtrati da una spiccata,
talora melodrammatica, performatività (non per nulla la Sexton non apprezzò
mai letichetta confessional, preferendo definirsi una storyteller),
come nel caso della famosa The Ballad of the Lonely Masturbator,
audace e ironico canto di riappropriazione del corpo e del piacere
femminile in una società perbenista come quella americana dellepoca, agli
albori della rivoluzione sessuale. Ma tale riappropriazione, più che
politicamente rivendicativa, discende dalla perdita dellamante, ed è
quindi frutto di un dolore che in realtà inscena la debolezza e insicurezza
della donna, la quale si sdilinquisce rievocando gli incontri perduti con
il suo uomo e meditando sulle menzogne dellamore. Anche la splendida Usè percorsa da una forte drammatizzazione poetica, in cui
lamplesso diviene una sorta di unio mystica dalla quale far
scaturire un oro che è quasi un simbolo alchemico di rinascita corporea e
spirituale. Se lesaltante esperienza erotica funziona qui da grimaldello
emancipatorio, persino in questo caso la donna risulta volontariamente
agita dalluomo, da lui liberata dagli orpelli della sua vita borghese e
incoronata principessa. Mentre in Us lamante è il tramite per
lestasi, in December 11th che fa parte di una serie di testi
intitolata Eighteen Days Without You, esito della rottura della
relazione con Zweizung la sua assenza sprofonda la donna in una solitaria rêverie mnestica improntata, ancora, a
unappassionata nostalgia per il corpo maschile e i passati incontri
amorosi. Infine, la traboccante sessualità di The Fierceness of the Female si confronta con un Dio-amante al
quale offrire un orgasmo che è insieme grata affermazione vitalistica per
leros e proclamazione di una fierezza femminile che va oltre il maschile
e sfida persino il divino disincarnato. Perfetta bussola per la ricchezza e
reversibilità dei ruoli amorosi nella poesia della Sexton è, in fondo,
lepigrafe che, da un saggio di W.B. Yeats, introduce proprio Love Poems: «One should say before sleeping, I have lived many
lives. I have been a slave and a prince. Many a beloved has sat upon my
knees e I have sat upon the knees of many a beloved. Everything that has
been shall be again.»[1]. (chiara serani)
[1]«Ci si dovrebbe dire, prima del sonno: Ho vissuto molte vite. Sono
stato uno schiavo e un principe. Molti amori ho tenuto sulle
ginocchia e sulle ginocchia mi hanno tenuto molti amori. Tutto ciò
che è stato, di nuovo sarà» (traduzione C. Serani).
The Ballad of the Lonely Masturbator
The end of the affair is always death.
Shes my workshop. Slippery eye,
out of the tribe of myself my breath
finds you gone. I horrify
those who stand by. I am fed.
At night, alone, I marry the bed.
Finger to finger, now shes mine.
Shes not too far. Shes my encounter.
I beat her like a bell. I recline
in the bower where you used to mount her.
You borrowed me on the flowered spread.
At night, alone, I marry the bed.
Take for instance this night, my love,
that every single couple puts together
with a joint overturning, beneath, above,
the abundant two on sponge and feather,
kneeling and pushing, head to head.
At night, alone, I marry the bed.
I break out of my body this way,
an annoying miracle. Could I
put the dream market on display?
I am spread out. I crucify.
My little plum
is what you said.
At night, alone, I marry the bed.
Then my black-eyed rival came.
The lady of water, rising on the beach,
a piano at her fingertips, shame
on her lips and a flutes speech.
And I was the knock-kneed broom instead.
At night, alone, I marry the bed.
She took you the way a woman takes
a bargain dress off the rack
and I broke the way a stone breaks.
I give back your books and fishing tack.
Todays paper says that you are wed.
At night, alone, I marry the bed.
The boys and girls are one tonight.
They unbutton blouses. They unzip flies.
They take off shoes. They turn off the light.
The glimmering creatures are full of lies.
They are eating each other. They are overfed.
At night, alone, I marry the bed.
Ballata della masturbatrice solitaria
La faccenda si conclude sempre con la morte.
È lei la mia officina. Locchio infido,
dalla tribù di me stessa è il respiro
che ti scopre sparito. Terrorizzo
chi mi sta vicino. Mangio.
La notte, da sola, sposo il mio letto.
Un dito dopo laltro, la faccio mia.
È a portata di mano. Me la trovo davanti.
La suono come una campana. Mi stendo
nel canto doveri solito montarla.
Mi prendevi in prestito sulla coperta a fiori.
La notte, da sola, sposo il mio letto.
Pensa per esempio a stanotte, amore mio:
ogni singola coppia si unisce,
allunisono sinverte sossopra,
unabbondanza fatta di due su gomma e spugna,
in ginocchio, spingendo, testa a testa.
La notte, da sola, sposo il mio letto.
Così facendo schizzo via dal corpo,
è un miracolo irritante. Posso forse esibire
il mercatino dei sogni?
Sono spalancata. Mi tormento.
Mia piccola susina, dicevi.
La notte, da sola, sposo il mio letto.
Alla fine venne la rivale dagli occhi neri.
La signora delle acque, sorta dalla riva,
un pianoforte alle dita, la vergogna
sulle labbra e parole flautate.
Io, un manico di scopa con le gambe storte.
La notte, da sola, sposo il mio letto.
Ti prese come una donna che prende
un vestito a saldo da uno scaffale,
e io mi sbriciolai come una pietra.
Ti rendo i libri e la roba da pesca.
Dice il giornale che non sei più scapolo.
La notte, da sola, sposo il mio letto.
Ragazzi e ragazze stanotte sono tuttuno.
Sbottonano camicie. Abbassano cerniere.
Si tolgono le scarpe. Spengono la luce.
Creature scintillanti colme di menzogne.
Si mangiano lun laltra. Sono sazi.
La notte, da sola, sposo il mio letto.
*
Us
I was wrapped in black
fur and white fur and
you undid me and then
you placed me in gold light
and then you crowned me,
while snow fell outside
the door in diagonal darts.
While a ten-inch snow
came down like stars
in small calcium fragments,
we were in our own bodies
(that room that will bury us)
and you were in my body
(that room that will outlive us)
and at first I rubbed your
feet dry with a towel
because I was your slave
and then you called me princess.
Princess!
Oh then
I stood up in my gold skin
and I beat down the psalms
and I beat down the clothes
and you undid the bridle
and you undid the reins
and I undid the buttons,
the bones, the confusions,
the New England postcards,
the January ten oclock night,
and we rose up like wheat,
acre after acre of gold,
and we harvested,
we harvested.
Noi
Io ero avvolta in una pelliccia
bianca, e nera, e tu
me la togliesti e poi
mi adagiasti nella luce doro
dove mi hai incoronata
mentre dardi di neve
fioccavano di sbieco alla porta.
Quella spanna di neve cadeva
come una pioggia di stelle
in briciole di calcio,
e noi eravamo nei nostri corpi
(quella stanza che ci seppellirà)
e tu nel mio corpo
(quella stanza che ci sopravvivrà)
e dapprima con un panno
ti asciugai i piedi
perché ero la tua schiava
quando tu mi proclamasti principessa.
Principessa!
Ed ecco, allora
io sórsi nella mia pelle doro
e mi sbarazzai dei salmi
mi sbarazzai dei vestiti
e tu sciogliesti le briglie
sciogliesti le redini
e io slacciai i bottoni
scardinai le ossa, le incertezze,
le cartoline del New England,
le notti di gennaio alle dieci,
e noi ci levammo su come grano,
campi e campi doro,
e mietemmo, noi
mietemmo.
*
December 11th
Then I think of you in bed,
your tongue half chocolate, half ocean,
of the houses that you swing into,
of the steel wool hair on your head,
of your persistent hands and then
how we gnaw at the barrier because we are two.
How you come and take my blood cup
and link me together and take my brine.
We are bare. We are stripped to the bone
and we swim in tandem and go up and up
the river, the identical river called Mine
and we enter together. No ones alone.
Undici dicembre
Ed è a te che penso, a letto,
alla tua lingua doceano e cioccolato,
alle case in cui svicoli via,
a quei capelli che hai di lana dacciaio,
così alle tue mani onnipresenti, e poi
a come in due erodiamo la barriera di essere due.
A come vieni e impugni la mia coppa di sangue,
riunendomi a me, bevendo il mio mare.
Nudi. Siamo nudi fino allosso
e nuotiamo insieme, su sempre più
su per il fiume, per lidentico fiume di me stessa
in cui insieme ci inoltriamo. Nessuno da sé.
The Fierceness of Female
I am spinning,
I am spinning on the lips,
they remove my shadow,
my phantom from my past,
they invented a timetable of tongues,
that take up all my attention.
Wherein there is no room.
No bed.
The clock does not tick
except where it vibrates my 4000 pulses,
and where all was absent,
all is two,
touching like a choir of butterflies,
and like the ocean,
pushing toward land
and receding
and pushing
with a need that gallops
all over my skin,
yelling at the reefs.
I unknit.
Words fly out of place
and I, long into the desert,
drink and drink
and bow my head to that meadow
the breast, the melon in it,
and then the intoxicating flower of it.
Our hands that stroke each other
the nipples like baby starfish
to make our lips sucking into lunatic rings
until they are bubbles,
our fingers naked as petals
and the world pulses on a swing.
I raise my pelvis to God
so that it may know the truth of how
flowers smash through the long winter.
La fierezza della femmina
Roteo,
roteo sulle labbra,
mi spogliano dellombra
e del fantasma del passato
forgiando uno scandire di lingue
che mi assorbe interamente.
E non vi sono stanze, lì,
né un letto.
Lorologio non batte
se non al vibrare delle mie 4000 pulsazioni,
e dove tutto era assenza
tutto è due,
due che si toccano come un coro di farfalle,
e come loceano,
che si protende alla terra
e arretra
e si protende
con quellurgenza che mi galoppa
ovunque sulla pelle,
gridando agli scogli.
Mi sciolgo.
Le parole volano fuori sesto
e io, da tempo nel deserto,
bevo e bevo
e riverisco quel giardino,
il seno, il melone che alberga
e il suo fiore inebriante.
Le nostre mani che si sfiorano lun laltra
i capezzoli come piccole stelle marine
per fare delle labbra avidi anelli di follia
sino a che non diventano bolle,
sono nude come petali le dita
e il mondo pulsa ondeggiando.
Innalzo il ventre a Dio,
che si sappia la verità
su come i fiori fracassano il lungo inverno.
Chiara Seraniè Dottore di ricerca in letterature straniere moderne. Ha insegnato
Scrittura critica e Lingua inglese allUniversità di Pisa, dove si è
laureata in Lettere nel 2001. Si è occupata di postcolonialismo e poesia
anglofona moderna e contemporanea. Tra le sue pubblicazioni Salman Rushdie. La storia come sperectomia, Aracne 2010;The August Presence. T.S. Eliot nellopera di Philip Larkin, Aracne 2010; Teoria e prassi intralinguistica. Letture anagrammatiche di testi poetici
anglofoni moderni e contemporanei, Ets 2010;The Creation Story of Civilization. Cosmogonia e mito eroico nellopera di
Ted Hughes, Ets 2010. Ha pubblicato saggi in volumi collettanei e su rivista, tra cui Strumenti Critici, Anglistica Pisana, Soglie e Il Grandevetro. È traduttrice freelance dallinglese allitaliano.
Illustrazione tratta da Pinterest
![Fabio Orecchini - PER OS Fabio Orecchini - Per os]() Fabio Orecchini - Per Os - Sigismundus Editrice, 2016
Fabio Orecchini - Per Os - Sigismundus Editrice, 2016 Fabio Orecchini - Per Os - Sigismundus Editrice, 2016
Fabio Orecchini - Per Os - Sigismundus Editrice, 2016
 Annoverata tra quei confessional poets che negli anni Cinquanta e
Sessanta rivoluzionarono la scrittura poetica coeva con la messa in scena
di drammi personali ed esplorazioni sfrontate di interiorità ora realmente
patologiche, ora performativamente isteriche, Anne Sexton è stata di certo
una poetessa originale e innovativa. In parte, anche più di Sylvia Plath,
di cui fu amica e alla quale viene sempre accostata (anche qui, invero) in
un confronto che in genere la vede perdente. In realtà, la Sexton fu sì
meno colta e meno raffinata dellaltra ma, a rileggerla oggi, ben più
modernamente ambigua, soprattutto nei confronti della cruciale
rappresentazione, per entrambe, del rapporto uomo-donna. Se infatti la
Plath declina il suo immaginario di ribellione al maschile soprattutto
nella diade padre-marito, la Sexton si confronta con una quaterna
composta da padre, marito, amante e Dio e la investe di
unambivalenza in cui, per esempio, le figure dellamante e del divino si
sdoppiano e si moltiplicano di ruolo. Se lamante può, semplicemente,
essere donna (come fu anche, talora, nella vita della Sexton) o farsi, da
un punto di vista simbolico, figura edipico-paterna, Dio rappresenta sia
lipostasi suprema di un patriarcato puritano e repressivo sia un
accogliente rifugio materno verso cui anelare (e del resto la Sexton dirà
che Dio è donna). Al di là di questo precoce e antesignano tentativo di
andare oltre il genere, la Sexton scompagina le carte dellimperante
femminismo ideologico dellepoca (che invece della Plath fece,
notoriamente, il santino) proprio per la sua feconda irresolutezza nei
confronti del desiderio per luomo-amante. La relazione adulterina e i suoi
oggetti libidici rimangono difatti sempre in bilico tra volontà di fusione
e rifiuto doloroso, erotismo estatico e rabbia rivendicativa, liberazione
fisica e intimo senso di colpa, gioia e angoscia.
Annoverata tra quei confessional poets che negli anni Cinquanta e
Sessanta rivoluzionarono la scrittura poetica coeva con la messa in scena
di drammi personali ed esplorazioni sfrontate di interiorità ora realmente
patologiche, ora performativamente isteriche, Anne Sexton è stata di certo
una poetessa originale e innovativa. In parte, anche più di Sylvia Plath,
di cui fu amica e alla quale viene sempre accostata (anche qui, invero) in
un confronto che in genere la vede perdente. In realtà, la Sexton fu sì
meno colta e meno raffinata dellaltra ma, a rileggerla oggi, ben più
modernamente ambigua, soprattutto nei confronti della cruciale
rappresentazione, per entrambe, del rapporto uomo-donna. Se infatti la
Plath declina il suo immaginario di ribellione al maschile soprattutto
nella diade padre-marito, la Sexton si confronta con una quaterna
composta da padre, marito, amante e Dio e la investe di
unambivalenza in cui, per esempio, le figure dellamante e del divino si
sdoppiano e si moltiplicano di ruolo. Se lamante può, semplicemente,
essere donna (come fu anche, talora, nella vita della Sexton) o farsi, da
un punto di vista simbolico, figura edipico-paterna, Dio rappresenta sia
lipostasi suprema di un patriarcato puritano e repressivo sia un
accogliente rifugio materno verso cui anelare (e del resto la Sexton dirà
che Dio è donna). Al di là di questo precoce e antesignano tentativo di
andare oltre il genere, la Sexton scompagina le carte dellimperante
femminismo ideologico dellepoca (che invece della Plath fece,
notoriamente, il santino) proprio per la sua feconda irresolutezza nei
confronti del desiderio per luomo-amante. La relazione adulterina e i suoi
oggetti libidici rimangono difatti sempre in bilico tra volontà di fusione
e rifiuto doloroso, erotismo estatico e rabbia rivendicativa, liberazione
fisica e intimo senso di colpa, gioia e angoscia.
 Ricorrono i morti (e lasciamo perdere le barzellette al riguardo), è
il centenario della disfatta di Caporetto e, tertium datur, le due cose si
combinano in un poeta che ha avuto alterne fortune, come gran parte della
poesia dialettale italiana. Parlo di Delio Tessa e della
sua
Caporetto 1917, «Lè el dì di Mort, alegher!», Sonada quasi ona
fantasia,
contenuto in L'è el dì di mort, alegher ; De la del mur e altre liriche, a cura
di Dante Isella, Einaudi 1985, che peraltro è possibile reperire in rete,
anche se privo di apparato critico. Tessa, come afferma P.V. Mengaldo
includendolo nel suo Poeti italiani del Novecento, è "uno dei più
grandi del nostro Novecento senza distinzione di linguaggio", aggiungendo
che "il disinteresse per questo poeta è una vergogna per la critica
italiana" (ma si era nel 1978 e a quel tempo Isella, uno dei massimi
studiosi della letteratura lombarda, stava ancora lavorando sull'opera di
Tessa). Sta di fatto che questi giudizi possono essere ancora in parte
sottoscritti, poiché è certo vero che Tessa è un eccellente poeta, basta
leggerlo anche solo nelle "traduzioni" in lingua italiana per rendersene
conto, ma è anche vero che Tessa, come la poesia dialettale in genere (ma è
categoria però piuttosto generica, basti pensare alla reinvenzione
dialettale di Scataglini e la rilevanza particolare che assume un poeta che
amo, Emilio Rentocchini), rinnova qualche interesse nella critica. Cito a
mero titolo di esempio l'edizione della stessa opera a cura di Mauro
Bignamini, per i tipi delle Edizioni dell'Orso, 2014, che prende in esame
le concordanze dell'opera di Tessa a partire proprio dall'edizione
iselliana; e in ambito più generale, sempre a titolo di esempio, citerei i
volumi
LItalia a pezzi. Antologia dei poeti italiani in dialetto e in altre
lingue minoritarie tra Novecento e Duemila
, a cura di Manuel Cohen, Valerio Cuccaroni, Rossella Renzi, Giuseppe Nava
e Christian Sinicco per i tipi di Qwynplaine, 2014; e inoltre (ma qui siamo
decisamente sulla produzione attuale) Guardando per terra. Voci della poesia contemporanea in dialetto
(LietoColle 2011). Il Sud, come sempre, è minoranza nella minoranza, con
buona pace degli "eredi" di Pierro e Buttitta, sebbene non manchino anche
oggi voci molto interessanti (ad esempio gli apprezzabili Giuseppe Samperi
- v.
Ricorrono i morti (e lasciamo perdere le barzellette al riguardo), è
il centenario della disfatta di Caporetto e, tertium datur, le due cose si
combinano in un poeta che ha avuto alterne fortune, come gran parte della
poesia dialettale italiana. Parlo di Delio Tessa e della
sua
Caporetto 1917, «Lè el dì di Mort, alegher!», Sonada quasi ona
fantasia,
contenuto in L'è el dì di mort, alegher ; De la del mur e altre liriche, a cura
di Dante Isella, Einaudi 1985, che peraltro è possibile reperire in rete,
anche se privo di apparato critico. Tessa, come afferma P.V. Mengaldo
includendolo nel suo Poeti italiani del Novecento, è "uno dei più
grandi del nostro Novecento senza distinzione di linguaggio", aggiungendo
che "il disinteresse per questo poeta è una vergogna per la critica
italiana" (ma si era nel 1978 e a quel tempo Isella, uno dei massimi
studiosi della letteratura lombarda, stava ancora lavorando sull'opera di
Tessa). Sta di fatto che questi giudizi possono essere ancora in parte
sottoscritti, poiché è certo vero che Tessa è un eccellente poeta, basta
leggerlo anche solo nelle "traduzioni" in lingua italiana per rendersene
conto, ma è anche vero che Tessa, come la poesia dialettale in genere (ma è
categoria però piuttosto generica, basti pensare alla reinvenzione
dialettale di Scataglini e la rilevanza particolare che assume un poeta che
amo, Emilio Rentocchini), rinnova qualche interesse nella critica. Cito a
mero titolo di esempio l'edizione della stessa opera a cura di Mauro
Bignamini, per i tipi delle Edizioni dell'Orso, 2014, che prende in esame
le concordanze dell'opera di Tessa a partire proprio dall'edizione
iselliana; e in ambito più generale, sempre a titolo di esempio, citerei i
volumi
LItalia a pezzi. Antologia dei poeti italiani in dialetto e in altre
lingue minoritarie tra Novecento e Duemila
, a cura di Manuel Cohen, Valerio Cuccaroni, Rossella Renzi, Giuseppe Nava
e Christian Sinicco per i tipi di Qwynplaine, 2014; e inoltre (ma qui siamo
decisamente sulla produzione attuale) Guardando per terra. Voci della poesia contemporanea in dialetto
(LietoColle 2011). Il Sud, come sempre, è minoranza nella minoranza, con
buona pace degli "eredi" di Pierro e Buttitta, sebbene non manchino anche
oggi voci molto interessanti (ad esempio gli apprezzabili Giuseppe Samperi
- v.
 iverso uso plastico della
lingua), è poeta in cui la scritturaè ricerca di rassicurazione e
identità. Lo è per diversi aspetti, a cominciare dal suo "sforzo di frenare
o addirittura di arrestare il flusso del tempo, di illuminarne una fermata" (Umberto Fiori in prefazione), il che mi pare significhi,
anche alla luce dei testi di questo libro, non solo una ricognizione per
momenti e luoghi topici della propria vita, ma anche la ricerca in essi del
proprio essere attuale. E' in altre parole un ragionato ritorno a casa
(dovunque in realtà essa sia), in cui però la nostalgia ha un'importanza
relativa, è più motivo lirico/elegiaco che epico o tragico, poiché mi pare
vi manchi un'eco lancinante, come se Di Spigno di quella "casa"
riconoscesse più la forza evocativa e identitaria che la sua mancanza.
Luogo che tuttavia certamente non "sembra proprio una casa qualunque e
indolore" (in La nudità, Pequod, 2010, v.
iverso uso plastico della
lingua), è poeta in cui la scritturaè ricerca di rassicurazione e
identità. Lo è per diversi aspetti, a cominciare dal suo "sforzo di frenare
o addirittura di arrestare il flusso del tempo, di illuminarne una fermata" (Umberto Fiori in prefazione), il che mi pare significhi,
anche alla luce dei testi di questo libro, non solo una ricognizione per
momenti e luoghi topici della propria vita, ma anche la ricerca in essi del
proprio essere attuale. E' in altre parole un ragionato ritorno a casa
(dovunque in realtà essa sia), in cui però la nostalgia ha un'importanza
relativa, è più motivo lirico/elegiaco che epico o tragico, poiché mi pare
vi manchi un'eco lancinante, come se Di Spigno di quella "casa"
riconoscesse più la forza evocativa e identitaria che la sua mancanza.
Luogo che tuttavia certamente non "sembra proprio una casa qualunque e
indolore" (in La nudità, Pequod, 2010, v. Writing-Surrealism (suggerito dalla mostra "I Rivoluzionari del 900",
Palazzo Albergati, Bologna)
Writing-Surrealism (suggerito dalla mostra "I Rivoluzionari del 900",
Palazzo Albergati, Bologna)









 lizia, e per di più gratis: Bloatware I - Incrostazioni (o dell'amor molesto), un libretto. Trattasi di giuoco o sberleffo se preferite, di/a/da/in/con/su/per/tra/fra la poesia come materia più malleabile di quanto possa sembrare e contemporaneamente materiale di scarto, garbage, déchet, rumenta - sia detto con tutta la simpatia possibile verso i poeti, me compreso. Un minuscolo cut 'n' paste nato da perplessità, soprassalti e divertimenti ricevuti nella maggior parte dei casi da poesie di terzi che mi è stato chiesto di leggere in varie occasioni. Frammenti autentici estrapolati e rimontati a piacere ironicamente et sine iniuria. Non so se avrà un seguito, ma roba ce ne sarebbe.
lizia, e per di più gratis: Bloatware I - Incrostazioni (o dell'amor molesto), un libretto. Trattasi di giuoco o sberleffo se preferite, di/a/da/in/con/su/per/tra/fra la poesia come materia più malleabile di quanto possa sembrare e contemporaneamente materiale di scarto, garbage, déchet, rumenta - sia detto con tutta la simpatia possibile verso i poeti, me compreso. Un minuscolo cut 'n' paste nato da perplessità, soprassalti e divertimenti ricevuti nella maggior parte dei casi da poesie di terzi che mi è stato chiesto di leggere in varie occasioni. Frammenti autentici estrapolati e rimontati a piacere ironicamente et sine iniuria. Non so se avrà un seguito, ma roba ce ne sarebbe.  n epoca, per superare i luoghi comuni dellaconfessione personale e trasformarsi in coralità conoscitiva della materia
linguistica. È la ricerca del vero che muta e (incupisce o illumina?) il
patema di essere vivi nellestro creativo dellesistenza. Per questo motivo
occorrono simboli autentici e spontanei per ipotizzare e/o negare esempi
tematici e stilistici. Alcuni autori viventi mantengono valido e saldo
questo assunto senza manifestare il narcisismo di artista, né
manomettere il moralismo. La parola detta di Stefania Di Lino La Vita
Felice, 2017, ne è testimonianza. Il ricordo, il tempo, la resilienza, si
connettono con la sperimentazione del verso che va oltre il noto e
prevedibile schema novecentesco. La lingua prende forma e definizione in
una tensione narrativa e narrante come una trasformazione genetica: il rigo
contiene lessenzialità del reciproco senso quotidiano e, nello stesso
tempo, pause/respiri (la punteggiatura ha il suo perché) dettati dal
mistero dellinteriorità e dal suo movimento verso lesterno. Poesie pregne
di problematiche umane sentite/lette nello stato profondo delle cose, con
impegno etico, con grazia, riconoscenza.
n epoca, per superare i luoghi comuni dellaconfessione personale e trasformarsi in coralità conoscitiva della materia
linguistica. È la ricerca del vero che muta e (incupisce o illumina?) il
patema di essere vivi nellestro creativo dellesistenza. Per questo motivo
occorrono simboli autentici e spontanei per ipotizzare e/o negare esempi
tematici e stilistici. Alcuni autori viventi mantengono valido e saldo
questo assunto senza manifestare il narcisismo di artista, né
manomettere il moralismo. La parola detta di Stefania Di Lino La Vita
Felice, 2017, ne è testimonianza. Il ricordo, il tempo, la resilienza, si
connettono con la sperimentazione del verso che va oltre il noto e
prevedibile schema novecentesco. La lingua prende forma e definizione in
una tensione narrativa e narrante come una trasformazione genetica: il rigo
contiene lessenzialità del reciproco senso quotidiano e, nello stesso
tempo, pause/respiri (la punteggiatura ha il suo perché) dettati dal
mistero dellinteriorità e dal suo movimento verso lesterno. Poesie pregne
di problematiche umane sentite/lette nello stato profondo delle cose, con
impegno etico, con grazia, riconoscenza.
 iberatoria si manifesta, in
questa raccolta delicata e intima, nella consapevolezza di vincere letà,
laffanno della perdita, la dedizione di ri-cominciare la vita. Alcune
illustrazioni contenute nel libro sono formule soddisfacenti per avvalorare
il senso poetico delle parole. Per aprirsi al cammino bisogna diminuire le
distanze: versi chiari e semplici per custodire elementi interiori e per
intuire il lato, troppo spesso oscuro, del percorso. Il viaggio, qui, è il
segreto misterioso della creazione. Lesperienza.
iberatoria si manifesta, in
questa raccolta delicata e intima, nella consapevolezza di vincere letà,
laffanno della perdita, la dedizione di ri-cominciare la vita. Alcune
illustrazioni contenute nel libro sono formule soddisfacenti per avvalorare
il senso poetico delle parole. Per aprirsi al cammino bisogna diminuire le
distanze: versi chiari e semplici per custodire elementi interiori e per
intuire il lato, troppo spesso oscuro, del percorso. Il viaggio, qui, è il
segreto misterioso della creazione. Lesperienza.
 oce. Verità e realtà sono fili conduttori di
questa elegante plaquette in cui lautore investiga e denuncia, senza
artifici retorici, le inquietudini del mondo rivendicando il pensiero
intellettuale come prima casa. Letica valoriale illumina il
pensiero poetico esaltando, così come accade nella fotografia, il
significato dei gesti e limportanza della ricerca dei particolari.
Lindignazione e la tensione civile si incontrano nella dignità filosofica,
pienamente, inevitabilmente.
oce. Verità e realtà sono fili conduttori di
questa elegante plaquette in cui lautore investiga e denuncia, senza
artifici retorici, le inquietudini del mondo rivendicando il pensiero
intellettuale come prima casa. Letica valoriale illumina il
pensiero poetico esaltando, così come accade nella fotografia, il
significato dei gesti e limportanza della ricerca dei particolari.
Lindignazione e la tensione civile si incontrano nella dignità filosofica,
pienamente, inevitabilmente.
 Linarrivabile mosaicoAnterem Edizioni, 2017 , ex tra sistoleMarco Saya Edizioni, 2017) si
manifesta con forza di seduzione nel suo registro stilistico e
contenutistico. Un lavoro di recita e canto che si accolla la fatica
dellevoluzione della scrittura e del pensiero artistico/filosofico. La
sofferenza, la gioia, lamore infelice e/o corrisposto, lesperienza della
conoscenza, la vita, la morte e il tempo sono i temi ricorrenti. La lingua
rompe gli argini tra i rapporti logici/idea e limmagine. Le cose sono
suggestioni/sensazioni tattili che percorrono memoria, simbologia,
corrispondenze.
Linarrivabile mosaicoAnterem Edizioni, 2017 , ex tra sistoleMarco Saya Edizioni, 2017) si
manifesta con forza di seduzione nel suo registro stilistico e
contenutistico. Un lavoro di recita e canto che si accolla la fatica
dellevoluzione della scrittura e del pensiero artistico/filosofico. La
sofferenza, la gioia, lamore infelice e/o corrisposto, lesperienza della
conoscenza, la vita, la morte e il tempo sono i temi ricorrenti. La lingua
rompe gli argini tra i rapporti logici/idea e limmagine. Le cose sono
suggestioni/sensazioni tattili che percorrono memoria, simbologia,
corrispondenze.
 Viola Amarelli - Il cadavere felice - Edizioni Sartoria
Utopia, 2017
Viola Amarelli - Il cadavere felice - Edizioni Sartoria
Utopia, 2017 Elia Malagò - Lalange - Ed. Fuocofuochino, 2017
Elia Malagò - Lalange - Ed. Fuocofuochino, 2017 grande piacere, in aggiunta al post del 6 gennaio dedicato a Elia Malagò, il testo completo della plaquette lalange da cui avevo estratto solo due poesie, con la prefazione di Antonio Prete, seguito dall'altra breve raccolta pubblicata sempre da Fuocofuochino nel 2015, dal titolo del disamore, con prefazione di Zena Roncada. Entrambe le plaquettes dovrebbero rientrare, insieme a diversi altri testi, nel prossimo libro a cui Elia sta lavorando con impegno da qualche tempo, un lavoro che personalmente attendo con grande interesse. Con l'occasione ringrazio anche l'editore Afro Somenzari per la sua amichevole disponibilità.
grande piacere, in aggiunta al post del 6 gennaio dedicato a Elia Malagò, il testo completo della plaquette lalange da cui avevo estratto solo due poesie, con la prefazione di Antonio Prete, seguito dall'altra breve raccolta pubblicata sempre da Fuocofuochino nel 2015, dal titolo del disamore, con prefazione di Zena Roncada. Entrambe le plaquettes dovrebbero rientrare, insieme a diversi altri testi, nel prossimo libro a cui Elia sta lavorando con impegno da qualche tempo, un lavoro che personalmente attendo con grande interesse. Con l'occasione ringrazio anche l'editore Afro Somenzari per la sua amichevole disponibilità. Elliott Erwitt, Personae: un mondo in immagini (visto ai musei
S.Domenico a Forlì)
Elliott Erwitt, Personae: un mondo in immagini (visto ai musei
S.Domenico a Forlì)









 alpha beta Verlag, Meran/Merano, 2017
alpha beta Verlag, Meran/Merano, 2017 In questo tempo si può collocare la poesia di Alessia Iuliano nellalveo
del progresso letterario, infatti, lautrice, tramite una spontanea
evoluzione dellestetica e dello spirito, con lopera Ottobre nei viavai
soffia emozioni alla vita per sanare coscienze con un raro farmaco poetico.
Palese come questa poesia sia un puro atto di generosità verso platee
meritevoli, che dovrebbero preferirla senza esito alcuno alla luce di una
visione di un amore universale che abbatte qualsiasi forma di cecità
poetica:
In questo tempo si può collocare la poesia di Alessia Iuliano nellalveo
del progresso letterario, infatti, lautrice, tramite una spontanea
evoluzione dellestetica e dello spirito, con lopera Ottobre nei viavai
soffia emozioni alla vita per sanare coscienze con un raro farmaco poetico.
Palese come questa poesia sia un puro atto di generosità verso platee
meritevoli, che dovrebbero preferirla senza esito alcuno alla luce di una
visione di un amore universale che abbatte qualsiasi forma di cecità
poetica:

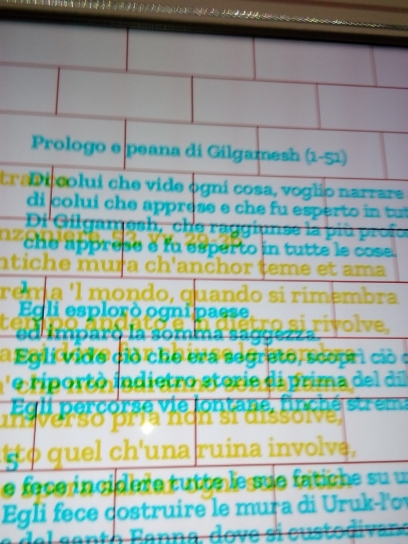
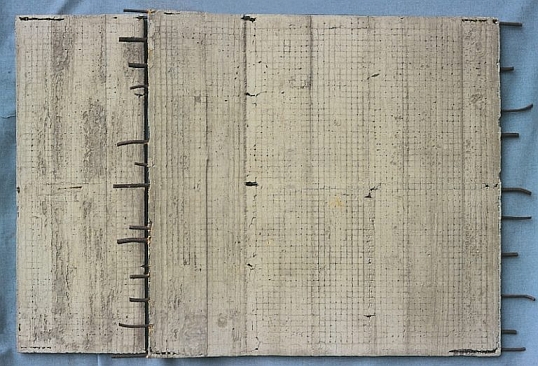




 Luigi Fontanella - Lo scialle rosso - Moretti e Vitali, 2017
Luigi Fontanella - Lo scialle rosso - Moretti e Vitali, 2017 edendomi che ne pensassi. Li ho letti con un certo interesse, perché
indubbiamente escono un po' dagli schemi, se si va oltre una impressione
non del tutto peregrina di forme crepuscolari innestate con dosi massicce
di simbolismo. Il primo appunto che ho preso, scritto a margine, è stato
per la verità "poesia barocchetta". Volendo forse significare con questo
non solo una scrittura con forti circonvoluzioni e priva di spazi aperti ma
anche dove il paesaggio, inteso in senso lato sia come naturale che umano,
si defila, a favore della costruzione, o si rappresenta come un fondale o una quinta, in una maniera che mi
ricorda l' Isola dei morti di Arnold Böcklin. In realtà qui, restando al barocco, c'è sì molta
complessità ma poco capriccio, perché il tema o quanto meno l'atmosfera prevalenti sono compatti e
concentrati, tendono a dare al lettore (e qui si torna al simbolismo) il suggerimento di una visione assai convinta e personale del mondo. Che è certo, coma
annota Anna Maria Curci (altre poesie appartenenti a questo blocco sono
state presentate su Poetarum Silva) un "mondo dissestato, funestato", per
quanto di "straniata bellezza", su cui Balbinot getta "una luce che non
teme di essere cruda". Sulla crudezza possiamo essere d'accordo, almeno se
si tiene conto del lessico e relativi annessi usati dall'autrice in
funzione espressionistica (e vale il breve accostamento che ancora Curci fa
a Gottfried Benn - si parva licet però): qui troviamo silenziato omicidio, acque fresche e pericolose, carnarie mosche, eterno gennaio, terreno
insanguinato, bagliori lucidi e freddi, qualcosa...di cruentemente esatto,
patiboli reconditi, leucemica fragilità, narrazione del sangue, consuntore
morbo, dissezione delle cose maestose, anni di espiazione e delle cerimonie
esequiali, esasperata desolazione, degenerativo stato, camera dei suicidi in un albergo, l'innominata carne ferita dei morti, e così via. Ma non è tanto una questione di sintagmi quanto di
costruzione anche sintatticamente complessa di un testo che definirei, per
usare parole della stessa autrice, "livido e sontuoso e torbido" (quindi se
barocco c'è, verrebbe da dire con una battuta, è barocco spagnolo). In
aggiunta a queste ultime parole citate, a volte si ha l'impressione che in
un certo qual modo Balbinot parli criticamente di sé quando scrive di
"estetismo nero e profetico" (o forse profetizzante, direi), o di "vasto mondo
crespuscolare". Ma anche in questi rari casi di espressioni didascaliche e
forse un po' ingenue l'obbiettivo è il tratteggio di una atmosfera
perturbante in cui il lettore deve accettare di permanere o no. Possiamo
aggiungere a queste cose un uso programmatico del lei (terza persona) come soggetto sostituto del tu (che come sappiamo è un ulteriore camuffamento dell'io poetico) e a volte
forme verbali al passato che accentuano abilmente uno straniamento di tipo
temporale e un senso di definitivo e tuttavia attuale. Immagino che questa lei sia l'autrice, immersa nel suo "mondo", che è di volta in volta "della
realtà", "crepuscolare" ma "aperto da ogni parte" (corsivo dell'autrice), "di silenzio", "bluastro", ma più che altro
"grigio" o di una "debole colorazione ossidata - di un metallico paesaggio" (c.vo aut.) e di svariate altre connotazioni. Ma soprattutto un mondo in
cui si avverte come una presenza di forze esterne non del tutto chiare né
del tutto controllabili, un mondo molto poco popolato, solo da lei, e da essi che se capisco bene non sono tanto "altri" quanto un "noi", cioè un plurale
di quello stesso lei, una condivisione dell'angoscia e forse il dolore che pervadono l'ambiente
e di cui l'ambiente è proiezione. E poi i morti, evocati non solo
direttamente ("nella loro innominata carne ferita") ma anche sotto forma di
aggettivi (morti occhi, vie, fiori, foglie, cime), o come correlati
semantici (mortalità, uccisioni, ad esempio). Insomma Balbinot ha
sviluppato un suo stile, con una certa accuratezza linguistica, con molti
echi, che aderisce bene alla tematica che si è scelta, e che in pari
misura, va da sé, può generare interesse o respingere. Per concludere: se
si aggiungono caratteri anche indubbiamente romantici come un certo senso
dell'assoluto o una certa irrazionalità o un'idea di sublime che sovrasta
l'uomo, allora cos'è che tiene insieme e fonde il barocco, il crepuscolare,
il simbolista, l'espressionista, il romantico? in altre parole cos'è la
poesia di Villa Dominica Balbinot? Ma è ovvio: è poesia gotica. (g. cerrai)
edendomi che ne pensassi. Li ho letti con un certo interesse, perché
indubbiamente escono un po' dagli schemi, se si va oltre una impressione
non del tutto peregrina di forme crepuscolari innestate con dosi massicce
di simbolismo. Il primo appunto che ho preso, scritto a margine, è stato
per la verità "poesia barocchetta". Volendo forse significare con questo
non solo una scrittura con forti circonvoluzioni e priva di spazi aperti ma
anche dove il paesaggio, inteso in senso lato sia come naturale che umano,
si defila, a favore della costruzione, o si rappresenta come un fondale o una quinta, in una maniera che mi
ricorda l' Isola dei morti di Arnold Böcklin. In realtà qui, restando al barocco, c'è sì molta
complessità ma poco capriccio, perché il tema o quanto meno l'atmosfera prevalenti sono compatti e
concentrati, tendono a dare al lettore (e qui si torna al simbolismo) il suggerimento di una visione assai convinta e personale del mondo. Che è certo, coma
annota Anna Maria Curci (altre poesie appartenenti a questo blocco sono
state presentate su Poetarum Silva) un "mondo dissestato, funestato", per
quanto di "straniata bellezza", su cui Balbinot getta "una luce che non
teme di essere cruda". Sulla crudezza possiamo essere d'accordo, almeno se
si tiene conto del lessico e relativi annessi usati dall'autrice in
funzione espressionistica (e vale il breve accostamento che ancora Curci fa
a Gottfried Benn - si parva licet però): qui troviamo silenziato omicidio, acque fresche e pericolose, carnarie mosche, eterno gennaio, terreno
insanguinato, bagliori lucidi e freddi, qualcosa...di cruentemente esatto,
patiboli reconditi, leucemica fragilità, narrazione del sangue, consuntore
morbo, dissezione delle cose maestose, anni di espiazione e delle cerimonie
esequiali, esasperata desolazione, degenerativo stato, camera dei suicidi in un albergo, l'innominata carne ferita dei morti, e così via. Ma non è tanto una questione di sintagmi quanto di
costruzione anche sintatticamente complessa di un testo che definirei, per
usare parole della stessa autrice, "livido e sontuoso e torbido" (quindi se
barocco c'è, verrebbe da dire con una battuta, è barocco spagnolo). In
aggiunta a queste ultime parole citate, a volte si ha l'impressione che in
un certo qual modo Balbinot parli criticamente di sé quando scrive di
"estetismo nero e profetico" (o forse profetizzante, direi), o di "vasto mondo
crespuscolare". Ma anche in questi rari casi di espressioni didascaliche e
forse un po' ingenue l'obbiettivo è il tratteggio di una atmosfera
perturbante in cui il lettore deve accettare di permanere o no. Possiamo
aggiungere a queste cose un uso programmatico del lei (terza persona) come soggetto sostituto del tu (che come sappiamo è un ulteriore camuffamento dell'io poetico) e a volte
forme verbali al passato che accentuano abilmente uno straniamento di tipo
temporale e un senso di definitivo e tuttavia attuale. Immagino che questa lei sia l'autrice, immersa nel suo "mondo", che è di volta in volta "della
realtà", "crepuscolare" ma "aperto da ogni parte" (corsivo dell'autrice), "di silenzio", "bluastro", ma più che altro
"grigio" o di una "debole colorazione ossidata - di un metallico paesaggio" (c.vo aut.) e di svariate altre connotazioni. Ma soprattutto un mondo in
cui si avverte come una presenza di forze esterne non del tutto chiare né
del tutto controllabili, un mondo molto poco popolato, solo da lei, e da essi che se capisco bene non sono tanto "altri" quanto un "noi", cioè un plurale
di quello stesso lei, una condivisione dell'angoscia e forse il dolore che pervadono l'ambiente
e di cui l'ambiente è proiezione. E poi i morti, evocati non solo
direttamente ("nella loro innominata carne ferita") ma anche sotto forma di
aggettivi (morti occhi, vie, fiori, foglie, cime), o come correlati
semantici (mortalità, uccisioni, ad esempio). Insomma Balbinot ha
sviluppato un suo stile, con una certa accuratezza linguistica, con molti
echi, che aderisce bene alla tematica che si è scelta, e che in pari
misura, va da sé, può generare interesse o respingere. Per concludere: se
si aggiungono caratteri anche indubbiamente romantici come un certo senso
dell'assoluto o una certa irrazionalità o un'idea di sublime che sovrasta
l'uomo, allora cos'è che tiene insieme e fonde il barocco, il crepuscolare,
il simbolista, l'espressionista, il romantico? in altre parole cos'è la
poesia di Villa Dominica Balbinot? Ma è ovvio: è poesia gotica. (g. cerrai)